

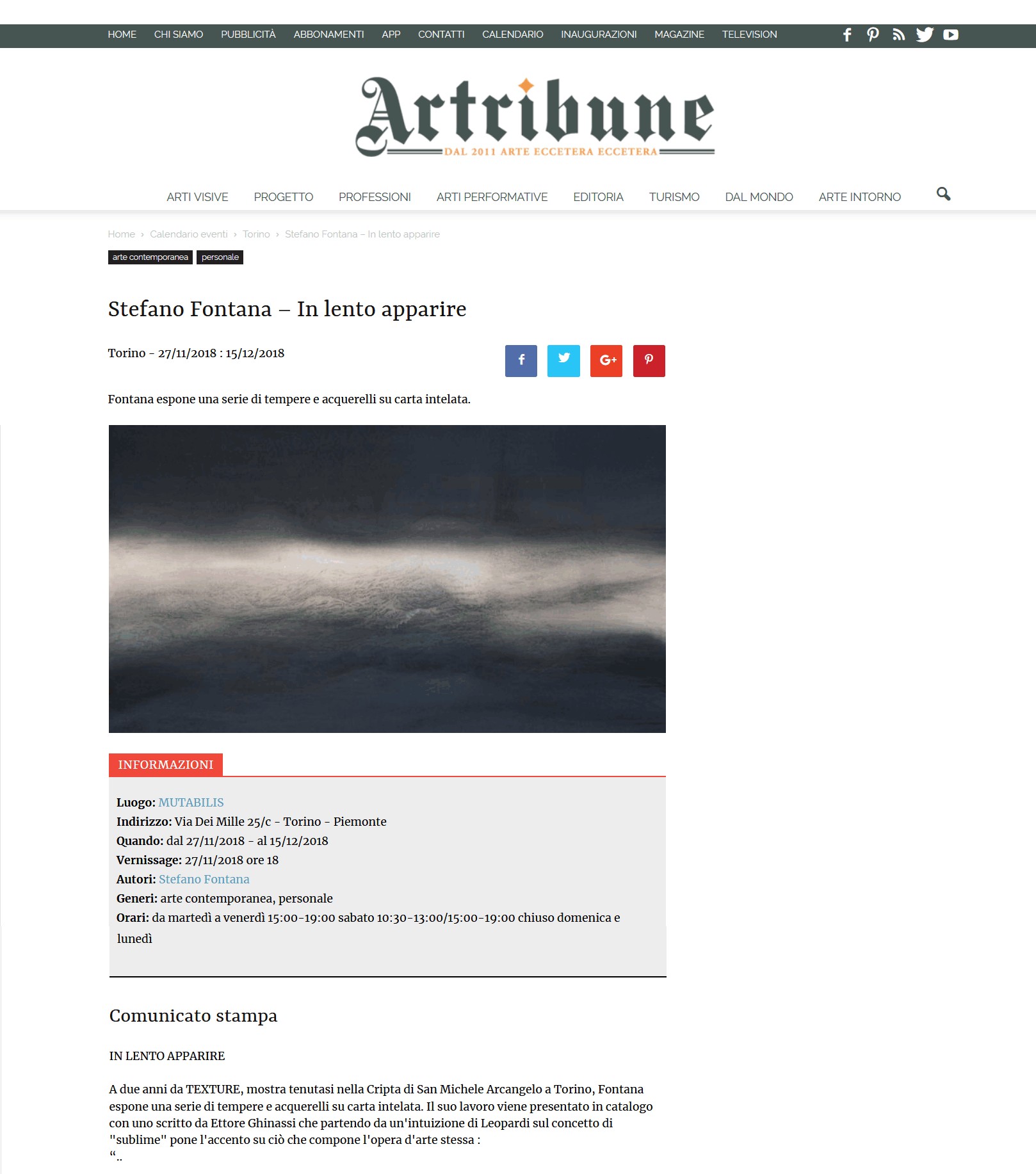
Un lento apparire
Negli atti di un labirintico convegno (1) sull’enigma di una parola millenaria – ‘Sublime’ – che un greco del I secolo d.c. , ancora ignoto sotto il nome di Pseudo-Longino, tentò per primo di decifrare, leggo questa sorprendente affermazione di Leopardi che trascrivo insie- me al brano che la contiene nel saggio di Giuliano Gramigna : “in una nota dello Zibaldone ( I, I06 I ) Leopardi scrive di Longino e del suo “Sublime”, al solo scopo di concludere che “i progressi della ragione della Civiltà” sono la causa dell’inaridirsi di tutti i livelli di subli- mità. (…) Muovendo da quel primo pretesto, però sempre lungo il filo degli effetti di subli- me, sulle idee ( diciamo le immagini ) che nascono dal testo, dalla sua particolare struttu- ra, e tuttavia sono diverse da quelle volute dal poeta. (…) Dopo qualche esitazione, con- clude che “ questa sarebbe la sorgente di una grande arte…immagini delle quali non sia evidente la ragione ma quasi nascosta, e tali che elle paiono accidentali e non procurate dal poeta in nessun modo, ma quasi ispirate da cosa invisibile e incomprensibile…”
Per Giuliano Gramigna la geniale intuizione di Leopardi introduce un’altra idea: “…m’imma- gino che qui sia in qualche modo accennato quel carattere di inatteso che viene a riempire una aspettativa, che ho creduto di individuare un po’ confusamente nel sublime”.
Di questa intrusione, di questo puro accadere che trama l’impensato sull’ordito del pensato ( del quale fa esperienza ogni pittore che non si alzi al mattino per finire giudiziosamente il lavoro lasciato interrotto la sera prima ) ho discusso molte volte e a lungo con Stefano, ma non credo con successo. Il fatto è che in Stefano Fontana vive il rifiuto neoplatonico per l’Idea che si disperde negli accidenti della Forma, lo inquieta che l’opera immaginata – va- gheggiata nella mente – non solo si corrompa nel farsi carne di materia formata, ma rechi con sé qualcosa che non ha il suggello dell’artefice, la traccia della sua identità. Il dominio su ogni fase del processo creativo – sapienza della pittura che conosce la vita delle mate- rie e il governo della mano – è un’urgenza in lui altrettanto forte e cogente della decisione di non abbandonare il dato di realtà, il mondo colorato delle cose animate e inanimate. Se- condo il suo sentire ( un sentire con una secolare, luminosa storia ) la sorgente stessa dell’arte. Perché il mondo per i pittori esiste solo per essere dipinto, o meglio, solo quando viene dipinto, generato su una tela, esiste. Ma va detto subito, per evitare fraintendimenti, che nel caso di Stefano non si tratta di realismo o naturalismo, né di una qualche maniera aggiornata di neo-figurazione ; soprattutto nelle opere recenti, sul tema dell’acqua che da tempo lo affascina, la sua ricerca si muove sempre di più verso una figuratività prosciuga- ta, smagrita, condensata in una grafia quasi astratta, spoglia di qualsiasi traccia di rappre- sentazione analogica. Anche quando l’impostazione iniziale dell’opera è costruita su una immagine fotografica – che egli trascrive sulla carta preparata con una sorta di scansione da settecentesca camera ottica – il suo sviluppo è un processo di sottrazione, di riduzione dell’immagine al suo disegno nascosto, alle sue nervature, alle sue linee di forza, come in un corpo al suo sistema nervoso, alle ramificazioni dei vasi e delle arterie. Ne emerge, per calcinazione del superfluo, una calligrafia pittorica raffinatissima, vigilata dalle sue osses- sioni: l’amatissimo Friedrich, la pittura Edo e Meji, i prodigiosi fogli di un anonimo pittore ci- nese del XIII secolo. E sempre per evitare equivoci, un “purovisibilismo” radicale, una radi- cale assenza di qualsivoglia indizio di senso che non sia quell’avida, inconfessabile brama di bellezza – nell’oggi stordito da una concezione ottusa di contemporaneità – che “brucia nel sangue” dei pittori “fin dalla giovinezza”. La bellezza: sostanza gassosa che si ottiene per sublimazione, per purificazione di materie fatte evaporare su una parete fredda: l’osti- nato rigore. Sono certo che così la intende Stefano, che con quella anacronistica parola negata si accapiglia e con essa nutre il proprio quotidiano travaglio. Come sono certo che a lui non sfugge, anche se è riluttante ad ammetterlo, che essa esige, nel cimento dell’armonia e dell’invenzione, almeno di una particella di azzardo: il manifestarsi, nel brancolamento della mano, nella catena dei tentativi e degli errori, di un“inatteso che viene a riempire una aspettativa”. Il ‘nuovo’ che erompe nel progetto fino a cancellarlo e innesca nell’opera la scintilla della propria autogenerazione. Tutto accade in quel primo evento. L’intenzione dell’artista, il suo lontano proposito latente ( “Idea” o “Concetto” secondo il grande eretico della Sistina ) si incarna nell’opera che generandosi lo genera, e lo porta a compimento. “ L’arte è un facere che è un perficere, e l’opera svela la propria insostituibile perfezione solo a chi sa coglierla nel processo con cui si adegua a se stessa” .
Non può essere frainteso che la perfezione nella tesi di Pareyson (Estetica, pag. 23) non trae alcuna ispirazione dall’universalità di un modello astratto, a una visione imposta dall’esterno. Perfezione e bellezza si intrecciano alla irripetibile singolarità dell’opera, esa- lano dalla potenza radiosa della sua legalità interna. L’opera riuscita ignora il proprio auto- re.
Tutto ciò io lo vedo nei magnifici quadri esposti in questa prima mostra importante di Stefa- no Fontana. Lo riconosco in “Nuovo orizzonte”, in “Pioggia”, nella serie degli “Improvvisi”, dove la coraggiosa ( e sofferta ) cancellazione degli sfondi – tributo residuo e superfluo all’inquadratura naturalistica – ha reso incantevole la ritmica, fluida grafia delle creste spu- meggianti dell’acqua ,e dei suoi moti di superficie, ammesso che ne sia ancora possibile l’identificazione. Lo riconosco in “Impromptu” dove l’occhio, a dispetto della mano, ha sa- puto captare il punto esatto di equilibrio fra densità e rarefazione, emersione e assorbi- mento delle stesure.
E ancora nel grande albero sotto la neve (“Bamboo”) , dove c’è l’albero e la neve , e c’è il vento e la tormenta e il freddo di una notte d’inverno, e non c’è niente di tutto questo e molto di più di tutto questo.
Sono ritornato all’incipit. Perché nell’inizio era già la fine, la conclusione del mio breve scritto: ciò che rende prodigiosa la grande arte sono “ le immagini delle quali non sia evi- dente la ragione ma quasi nascosta, e tali che elle paiono accidentali e non procurate dal poeta in nessun modo, ma quasi ispirate da cosa invisibile e incomprensibile…”…in un len- to apparire.
(1) in atti del convegno: “Dicibilità del Sublime”, Udine 1990, Giuliano Gramigna, “ Quando si nomina l’arcobaleno” (pag.57 ).
Ettore Ghinassi
Viareggio, ottobre 2018




